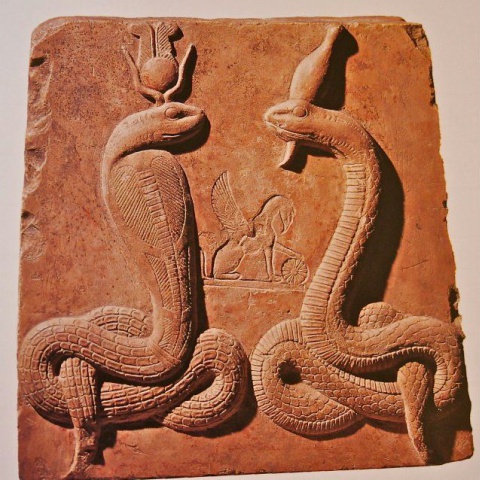
La psicoanalisi, come tutte le forme di conoscenza, si evolve continuamente. Come si esprime la psicoanalisi nel XXI secolo? La scoperta della relazionalità primaria dell’essere umano, l’osservazione dei bambini, l’esperienza clinica, i cambiamenti sociali, l’aumento della frequenza di alcuni sintomi e la diminuzione di altri, gli sviluppi delle neuroscienze, la nascita di nuovi disturbi, di nuove categorie psicodiagnostiche, e infine le teorie e i paradigmi successivi a Freud hanno arricchito enormemente la prospettiva psicoanalitica. Gli analisti hanno via via dato sempre meno importanza alle pulsioni e alle fasi biologiche ad esse legate, in favore degli stili relazionali del Soggetto umano con l’Altro dentro e fuori di sé. Parte del linguaggio di Freud, geniale iniziatore della psicoanalisi, è diventato ormai quasi un ostacolo alla comprensione profonda della psiche di un essere umano. Come sempre accade nella storia della scienza, le conoscenze progrediscono all’interno di un paradigma fino a un punto di rottura, che avviene tipicamente quando il paradigma esistente diventa un limite alla comprensione della realtà studiata. Mi sembra che la psicoanalisi stia attraversando una di queste fasi.
Negli ultimi anni, leggendo qua e là, ho trovato una concettualizzazione comprensiva, esplicativa, euristica e rispettosa della complessità della psiche umana negli scritti di Silvia Montefoschi (1926-2011), biologa, medico e psicoanalista junghiana. Il suo lavoro, che nasce come teoria della clinica a partire dalla visione junghiana dell'uomo, si sviluppa intorno al concetto di Soggetto riflessivo individuale inteso come organizzatore unico della psiche dell’essere umano, in un contesto che prevede l’esistenza di diversi livelli di coscienza possibili all'interno di una dinamica evolutiva universale che muove dall’Essere alla conoscenza che l’Essere fa via via di sé attraverso le forme che assume lungo la strada dell'evoluzione. Questo approccio mi sembra poter comprendere le recenti scoperte e osservazioni scientifiche; mi sembra coerente con le linee guida che hanno ispirato la scrittura del PDM, il manuale diagnostico psicodinamico; infine contiene in sé grandi potenzialità di sviluppo sia nel campo della diagnosi, sia in quello della terapia. Paolo Cozzaglio (Psichiatria intersoggettiva, 2014) sta contribuendo in modo fecondo ad articolare queste potenzialità.
Ecco qualche spunto che mi sembra descriva bene la situazione e la direzione della psicoanalisi all’inizio del XXI secolo: “I trattamenti che si focalizzano su sintomi o comportamenti isolati (anziché sui pattern interpersonali, emotivi e della personalità) non sono efficaci nel produrre cambiamenti, neppure se questi ultimi vengono definiti in senso stretto.” (PDM, 2006) “Le neuroscienze e gli studi sullo sviluppo sostengono in modo sempre più convincente l’idea che il funzionamento mentale normale e patologico sia un fenomeno molto articolato. Ignorare questa complessità significa ignorare ciò di cui ci stiamo occupando.” (ibidem) “È tempo di osservare realmente i fenomeni con cui abbiamo a che fare, e di adattare i nostri metodi ai fenomeni, anziché il contrario.” (ibidem) “Quando i terapeuti applicano trattamenti manualizzati a cluster selezionati di sintomi e non si occupano della persona che fa esperienza di questi ultimi e della relazione terapeutica sottesa al trattamento, i risultati terapeutici sono di breve durata e i tassi di ricadute elevati.” (ibidem)
“Ogni essere umano in cerca di un interlocutore, come appunto il paziente che va dall’analista, porta in sé l’esigenza di un particolare tipo d’incontro, quell’esperienza di un Tu che gli è stata preclusa e che avrebbe il potere di rivelargli il proprio Sé.” (Silvia Montefoschi, Opere complete) “Io non agisco direttamente sugli istinti, non sugli affetti, non sulla struttura psichica data come cosa; io mi rivolgo ad un soggetto nella misura in cui egli si rivolge a me.” (ibidem) “Il nuovo modello di rapporto che quindi si prospetta, nel momento in cui si rompe quello dell’interdipendenza fondato sul reciproco appagamento dei bisogni, è un modello di rapporto intersoggettivo che su null’altro si fonda se non sulla reciproca esistenza. […] Nell’instaurarsi dell’intersoggettività si colloca il momento dell’azione terapeutica, il suo strumento e la sua finalità”. (ibidem)
